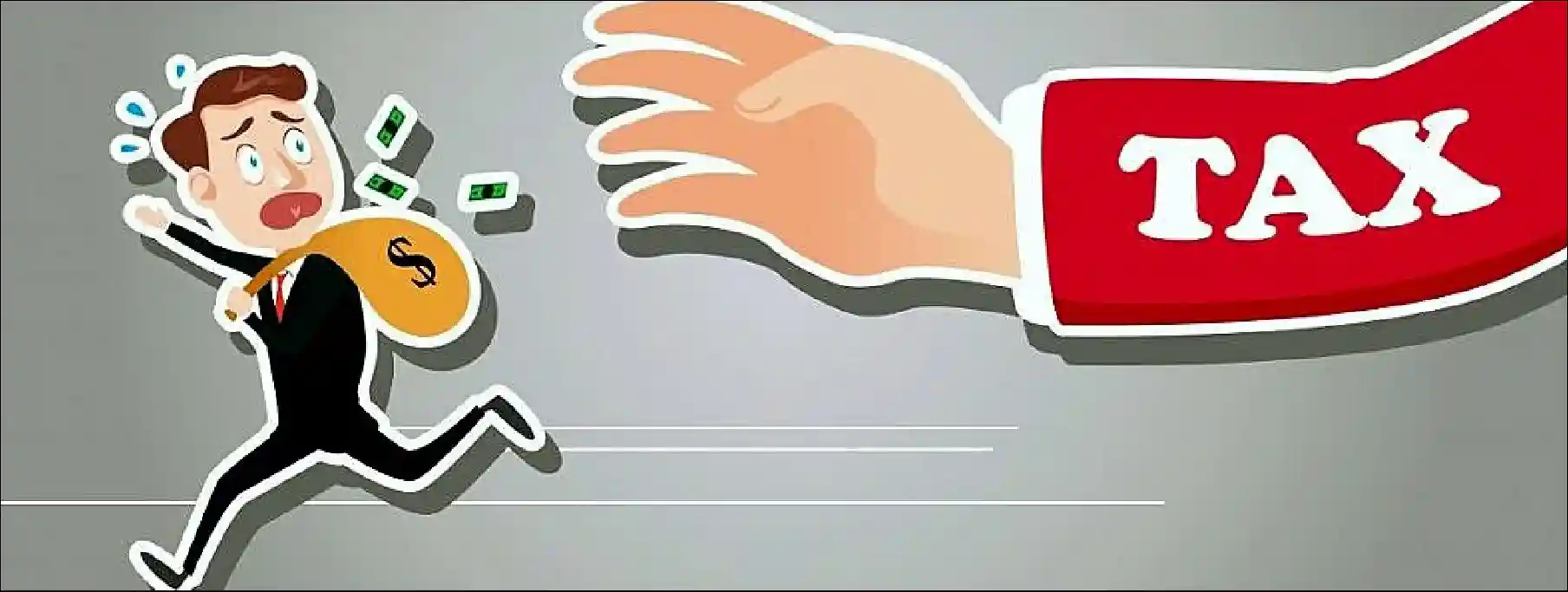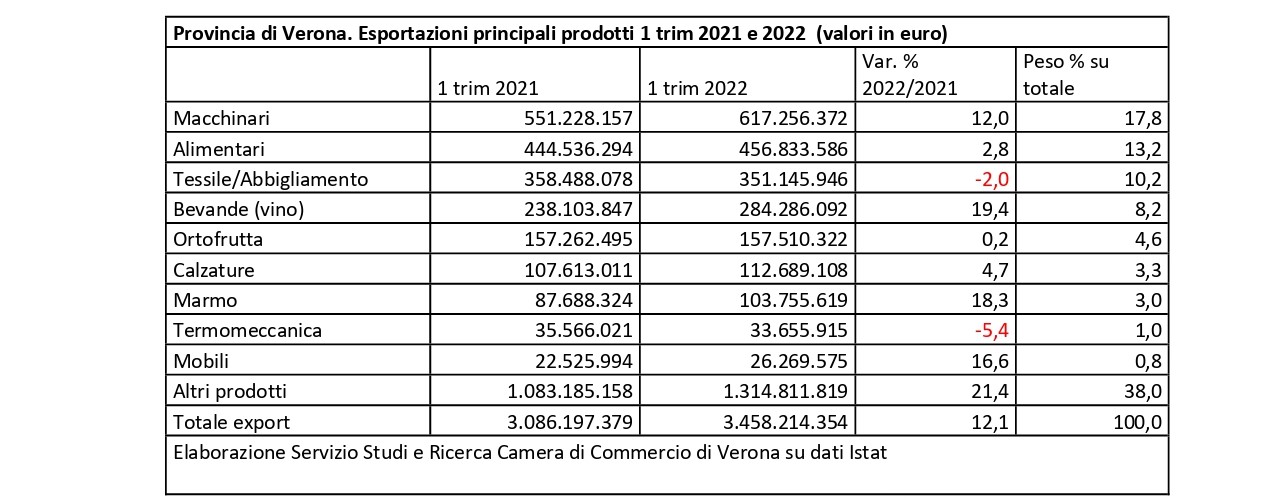(Avv. Francesco Corraro) È il primo gennaio 2024. Sono trascorsi pochi minuti dalla mezzanotte, quando nella mente del contribuente prende forma il più nobile dei buoni propositi per l’anno appena iniziato: cambiare casa! Dire addio all’attuale abitazione – che con il proliferare del nucleo familiare è diventata sempre più stretta – per approdare in spazi più ampi, ariosi e consoni alla nuova vita domestica.
Le finanze, tuttavia, languono. Cosicché l’unico modo per reperire la liquidità necessaria da aggiungere a quella che la banca vorrà benevolmente mutuare, è liberarsi del vecchio immobile.
Insomma, vendere prima di comprare. Capita, però, che, pur affidandosi al più blasonato degli agenti immobiliari su piazza, quello che promette di vendere in quattro e quattr’otto al prezzo voluto, passano giorni, settimane e mesi in cui gli unici interessati all’acquisto sono speculatori di professione.
Finché, un giorno, colpo di scena: ben due acquirenti disposti a pagare esattamente il prezzo richiesto dal venditore. Solo che uno di loro è interessato alla nuda proprietà. L’altro all’usufrutto.
Al venditore, che non si perde certo in meandri giuridici, poco importa chi compra cosa. Per lui, la suddivisione dei diritti reali voluta dagli acquirenti è roba da istituzioni di diritto privato: del tutto irrilevante! Ciò che davvero conta è cedere l’immobile per incassare l’intero corrispettivo pattuito. Il resto è forma, non sostanza.
Se non fosse, però, che mentre tutti brindavano all’anno nuovo, il Legislatore, con la Legge n. 213, del 30 dicembre 2023, e precisamente con l’art. 1, comma 92, ritoccando l’art. 9, comma 5 e l’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR, forgiava una modifica normativa talmente foriera di interpretazioni ambigue che, come una profezia nefasta, non ha tardato a manifestare tutta la sua carica distorsiva nel testo della Risposta ad interpello n. 133/2025 dell’Agenzia delle Entrate: una sorta di pietra filosofale al contrario, in grado non di generare oro, ma di trasformare una semplice compravendita in un concentrato di tassazione del tutto inaspettato.
Eh già, perché l’Amministrazione finanziaria, smembrando l’unità economica dell’operazione, afferma che la cessione della nuda proprietà genera una classica plusvalenza soggetta al corredo di esenzioni, esclusioni ed alleggerimenti previsti dall’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR.
La porzione di corrispettivo riferita all’usufrutto, invece, va incontro a ben altro e più gravoso regime impositivo.
Grazie ad un piccolo capolavoro di alchimia fiscale, realizzato con l’aria serafica di chi sta solo applicando la legge, ciò che per il contribuente è parte dello stesso prezzo, per il Fisco diventa, infatti, “reddito diverso” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR.
Il risultato? Nessun costo da dedurre! Nessuna esenzione o agevolazione da invocare! Solo IRPEF in misura piena da pagare fino all’ultimo centesimo e che, nel peggiore dei casi, potrebbe anche prosciugare quasi la metà dell’importo incassato!
Un paradosso tragicomico, dunque, dove chi ride è, neanche a dirlo, il Fisco; a piangere, invece, è, ça va sans dire, il contribuente colpevole non di frodi o elusioni varie, ma di essersi imbattuto, per sua sfortuna, in due acquirenti interessati a spartirsi la nuda proprietà e l’usufrutto dell’immobile messo in vendita. Forse, avrebbe dovuto premurarsi di far pubblicare un annuncio con scritto “Cercasi acquirente unico. Astenersi divisionisti”?
Un’incongruenza che sconfina nel grottesco e che inevitabilmente porta a domandarsi quale sia la logica – ammesso che ve ne sia una diversa da mere esigenze di cassa – in grado di sorreggere un impianto interpretativo tanto contorto quanto disancorato dalla realtà economica dell’operazione.
Già, perché, nella sostanza, è sotto gli occhi di tutti come il contribuente abbia solamente alienato l’intera proprietà dell’immobile, incassando un corrispettivo unitario. Che poi questo sia stato versato da un unico acquirente, o suddiviso tra coloro che, invece, hanno deciso di spartirsi la nuda proprietà e l’usufrutto, nulla cambia in termini di ricchezza effettivamente conseguita.
Stessa operazione economica, stesso risultato, ma due regimi impositivi radicalmente diversi.E allora, sorge spontaneo chiedersi: qual è la sorte del principio di capacità contributiva consacrato nell’art. 53 della Costituzione? E soprattutto, come si concilia una simile disparità di trattamento fiscale con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione?
Tant’è che persino il Consiglio Nazionale del Notariato, custode della forma per antonomasia, nel suo recente studio n. 14-2024/T, invita, con garbata autorevolezza, a considerare la sostanza dell’operazione prescindendo dalla sua veste formale.
Sostanza che, nel caso di specie, è talmente evidente da non lasciare margini di dubbio: una vendita, un prezzo, un trasferimento integrale. Punto.
Ma come mai, allora, la tanto sbandierata “prevalenza della sostanza sulla forma” – principio più volte invocato proprio dall’Agenzia delle Entrate e trasformato, come ben sanno gli addetti ai lavori, in un comodo grimaldello per riqualificare qualsiasi atto sospetto di produrre effetti fiscali meno gravosi – ora sparisce come per incanto?
Forse perché questa volta la sostanza fa bene al contribuente, risultando meno conveniente per l’Erario ed allora è meglio farla sparire sotto la coltre della forma? Chi può dirlo. Del resto, ogni alchimista sa che certi reagenti si usano solo quando tornano utili, altrimenti meglio accantonarli per non compromettere la funzionalità degli alambicchi.
E così, mentre l’alchimista fiscale porta a compimento la sua opera con apparente rigore tecnico, il contribuente osserva sgomento la riduzione del proprio corrispettivo e si chiede, non senza rammarico, se non fosse stato più saggio farsi assistere da chi conosce davvero gli incantesimi del Fisco e sa come spezzarne gli effetti.
Perché, è risaputo, in certi laboratori tributari, a volte, non è il diritto a prevalere, ma l’illusione ben costruita.