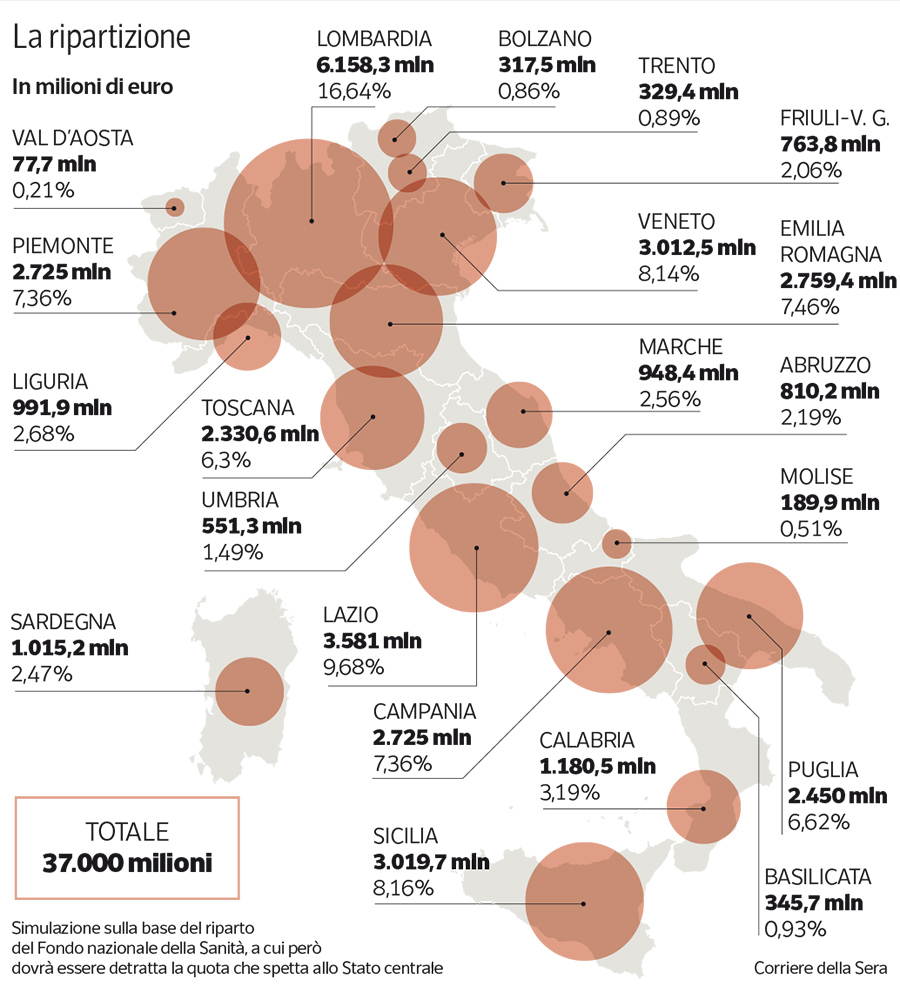(Angelo Paratico) 62 anni, la sera del 9 ottobre 1963, alle ore 22 e 39, si staccò l’apice di una montagna che cadde nel bacino della diga del Vajont. La diga resse ma lo tsunami che generò la frana provocò un immane disastro. La diga era situata in Erto e Casso, nella provincia di Pordenone, lungo il corso del torrente Vajont. Era stata progettata dal 1926 al 1959 dall’ingegnere Carlo Semenza ma dal giorno del disastro non è stata più usata per produrre energia elettrica.
Era una diga del tipo a doppio arco, costruita dall’impresa G. Torno & C. S.p.A. di Castano Primo (MI), una grande ditta che aveva costruito in tutto il mondo. Lo sbarramento era alto 261,60 metri e, a 62 anni dalla costruzione, è ancora l’ottava diga più alta del mondo. Quello fu e resta un capolavoro d’ingegneria. La diga resse all’impatto e alle sollecitazioni che furono quasi dieci volte superiori a quelle prevedibili durante il normale esercizio, una dimostrazione quindi della professionalità di chi aveva progettato e realizzato l’opera. Il problema è che non doveva essere costruita affatto in quel luogo.

Il progetto Vajont era stato fortemente voluto dalla Sade, azienda elettrica privata di proprietà del conte Giuseppe Volpi di Misurata (1877-1947), già presidente della confederazione degli industriali e ministro delle finanze durante il fascismo, ma prese forma dopo la II Guerra mondiale quando venne presentato il progetto esecutivo per l’approvazione del genio civile. La responsabilità della tragedia fu addossata ai progettisti e dirigenti della Sade, ente gestore dell’opera fino alla nazionalizzazione, i quali occultarono la non idoneità dei versanti del bacino, a rischio idrogeologico.
Mario Fabbri che a suo tempo fu giudice nel processo disse: «Venne nel mio ufficio un giovane avvocato che si chiamava Giovanni Leone, il quale mi disse di poter mettere sul tavolo dieci miliardi di vecchie lire per i risarcimenti». L’obiettivo del futuro capo dello Stato, ingaggiato dalla Sade era evidentemente quello di chiudere in fretta il caso, pagare i superstiti e sottrarre dall’azione penale i responsabili.
Sul provvedimento di “legittima suspicione” che portò a celebrare il processo a L’Aquila, Fabbri difese la scelta della Cassazione, contrariamente alla posizione di altri partecipanti al processo, in quanto: «Venezia era considerata la “Corte Cini” (proprietari della Sade) e dunque il processo di appello che si sarebbe celebrato a Venezia avrebbe incontrato ulteriori ostacoli”.
Sulla sentenza di primo grado de L’Aquila, Fabbri disse che: «Fu una cosa indegna! Il magistrato che presiedeva il Tribunale era bizzarro, e venne poi espulso dalla magistratura». Sulla stessa linea l’avvocato Sandro Canestrini che aggiunse: “Una montagna che si spostò di di 4 metri in tre anni, secondo la relazione parlamentare fu uno spostamento “impercettibile!”.
Si scandagliarono fatti e perizie e venne condannato l’ingegner Alberico Biadene, responsabile della Sade perché, quando vide piegarsi gli alberi sul monte Toc aveva ancora dieci ore per dare l’ordine di evacuazione. Eppure, non lo fece e si affidò invece alla Provvidenza.
Il disastro del Vajont, infatti, non fu causato da semplice incuria. La scelta di portare a termine l’opera a tutti i costi, nonostante vi fosse la consapevolezza dei gravi rischi presenti, fu determinata da forti interessi economici in gioco. Il subentro dell’Enel alla Sade prevedeva il pagamento degli impianti funzionanti e dunque dai vertici venne esercitata una continua pressione a farli entrare in funzione ad ogni costo e nel più breve tempo possibile.