(Alfonso Borgognone) Il mancato attacco all’Iran non è un segno di debolezza. Al contrario, è la fotografia più nitida della nuova politica estera americana a trazione trumpiana: muscolare, centralizzata, imprevedibile, ma profondamente intrecciata agli interessi economici e, soprattutto, energetici degli Stati Uniti.
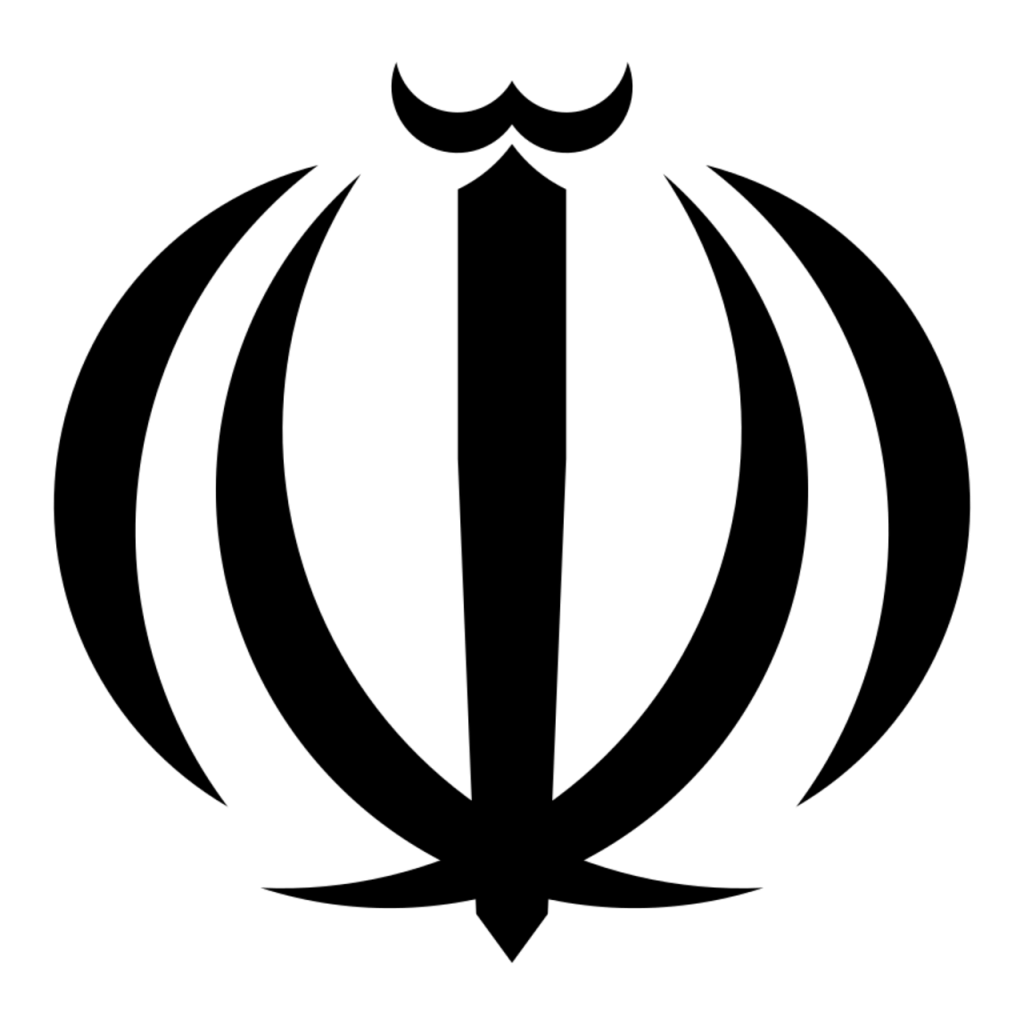
La decisione di Washington di congelare l’azione militare dopo la sospensione delle 800 esecuzioni da parte di Teheran va letta su più livelli. Sul piano umanitario, la Casa Bianca ha potuto rivendicare un successo politico senza sparare un colpo. Su quello geopolitico, Trump ha dimostrato di saper fermare la mano quando il contesto — e gli alleati regionali — lo richiedono. Ma è sul piano energetico che il calcolo appare più evidente.
I Paesi arabi, in particolare le monarchie del Golfo, hanno esercitato una pressione intensa per evitare un’escalation. Non per solidarietà verso l’Iran, bensì per autodifesa economica. Un conflitto aperto nel Golfo Persico avrebbe significato tensioni immediate sullo Stretto di Hormuz, volatilità estrema dei prezzi del greggio e un rischio concreto di recessione globale. In uno scenario simile, nessuno — né Riyad, né Doha, né Abu Dhabi — avrebbe avuto da guadagnare.
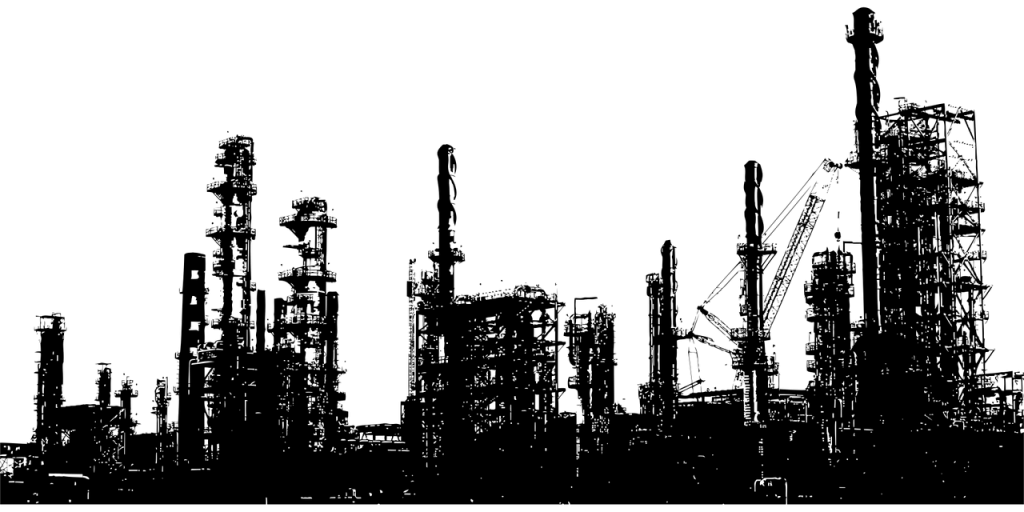
Trump ha ascoltato. Non per spirito multilaterale, ma perché oggi gli Stati Uniti si trovano in una posizione di forza senza precedenti sul fronte energetico. Grazie allo shale oil, l’America non è più ostaggio del Medio Oriente: è produttore dominante, arbitro dei prezzi, e concorrente diretto dei grandi esportatori tradizionali.
Trump mette le mani sul petrolio venezuelano
Ed è qui che entra in gioco il Venezuela, tornato lentamente nell’orbita americana. Il riavvicinamento — politico prima ancora che economico — consente a Washington di compensare eventuali shock mediorientali, riducendo la dipendenza da fornitori instabili e rafforzando il controllo sulle rotte energetiche occidentali. Un Venezuela “normalizzato” diventa un tassello chiave per tenere bassi i prezzi interni e neutralizzare il ricatto petrolifero di Teheran.

Trump lo sa bene: un’impennata del prezzo della benzina negli Stati Uniti sarebbe politicamente tossica. Per questo la pressione sull’Iran non passa solo dalle portaerei, ma dal mercato. Sanzioni, minacce e aperture tattiche servono a tenere Teheran sotto scacco senza incendiare i barili.
In questa logica, la sospensione delle esecuzioni iraniane diventa una valvola di sfogo diplomatica utile a tutti. A Teheran per guadagnare tempo. Ai Paesi arabi per stabilizzare la regione. A Trump per dimostrare che la forza americana non è solo militare, ma sistemica: capace di condizionare comportamenti, alleanze e flussi energetici.
Il risultato è una politica estera di assoluto protagonismo, in cui gli Stati Uniti non delegano più, non mediano in silenzio e non inseguono equilibri astratti. Agiscono, arretrano, colpiscono o si fermano in funzione di un unico obiettivo: preservare la centralità americana nell’economia globale.
La pace, secondo lo schema trumpiano, non è un valore in sé, ma una condizione conveniente. Finché il petrolio scorre, i mercati reggono e l’America resta al centro del gioco, la guerra può aspettare. Ma il messaggio a Teheran è chiaro: la pausa non è una tregua, è un avvertimento.




